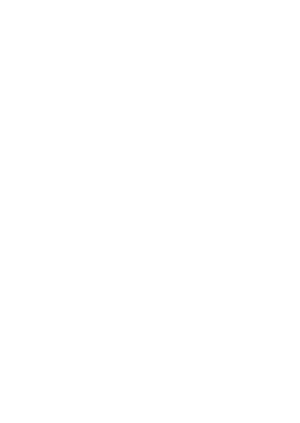Una riflessione per mettere una parte di quello che si è in quello che si fa
In questo tempo accelerato di cambiamenti all’insegna di molteplici transizioni (ecologica, digitale, energetica, demografica etc.) torna centrale la discussione sulle finalità dell’apprendimento nel più ampio dibattito sul senso del lavoro.
Le diverse posizioni al riguardo sembrano convergere su un punto: l’apprendimento è una pratica davvero rilevante e decisiva. Esploriamo meglio allora la questione lasciandoci interpellare da queste domande: per chi sarebbe decisivo apprendere? Quali obiettivi perseguirebbe? Quali benefici se ne potrebbero trarre?
Una duplice prospettiva
Tradizionalmente l’apprendimento ha perseguito due finalità:
- sviluppare risorse cognitive/abilità/comportamenti (hard, soft, character skill) individuali per “servire” le esigenze del business
- trasformare queste risorse, grazie all’arte combinatoria del management, in bene collettivo, facendolo diventare apprendimento organizzativo.
Ci siamo formati così pensando all’apprendimento secondo una duplice prospettiva: l’una individuale, l’altra organizzativa, entrambe lette però sempre con lenti funzionaliste. Queste lenti guardano l’apprendimento come strumento per far funzionare bene, meglio, in modo eccellente i collaboratori fin quando ciò sarà possibile, sono dunque lenti usa e getta.
Questo modo di pensare (e di vedere) sta mostrando le sue fragilità a causa della crisi che vive la funzione stessa dell’impresa che ne ha orientato sin qui anche lo sguardo sull’apprendimento. Oggi, infatti, l’impresa dilata il suo purpose che non è più quello di massimizzare le utilità di qualcuno (il profitto per gli azionisti) quanto quello di creare valore condiviso per tanti, secondo le idee portate avanti da oltre dieci anni da Michael E. Porter e Mark R. Kramer, rispettando l’ambiente, le persone, le aspettative di futuro delle nuove generazioni oltre di quelle che verranno.
Apprendimento performativo
Si fa largo così un’idea diversa che al posto dell’apprendimento performativo (per funzionare) lascia spazio a un apprendimento per vivere, per espandere l’umano, per stare meglio. Una domanda può guidare allora la riflessione, quella che attraversa le pagine di un saggio di qualche anno fa del filosofo e psicanalista Miguel Benasayag: «funzionare o esistere»?[1]
Le due prospettive evocate generano altrettanti approcci e sistemi di apprendimento ben diversi tra loro. Il primo, concentrato sulla performance, deve fare i conti con gli ostacoli posti dai limiti naturali inscritti nella fragilità umana. Per esempio, fin quando sarà conveniente per un’impresa e il suo management investire in programmi di apprendimento? Fino a quale età è immaginabile un tornaconto? Per questo i sistemi di apprendimento, e le scelte dei loro attori, andranno attentamente “sorvegliati” per determinarne il tempo della loro scadenza che ne sanzionerà inevitabilmente l’inutilità.
Il paradosso dell’apprendimento inutile
Il secondo approccio, che presta attenzione alla vita piuttosto che alla performance, recupera lo statuto di persona del lavoratore, smarcandosi dalla logica prestazionale che ineluttabilmente genera persone-che-lavorano ai margini e scarti umani prima che professionali. Questa diversa prospettiva, insomma, ci sfida con un paradosso: quello di dare cittadinanza organizzativa all’idea che anche ciò che è inutile può essere utile[2], e che quindi possa essere utile quell’apprendimento inutile che sviluppa la persona, ne espande le potenzialità aprendo sentieri di auto-realizzazione che generano benessere, generosità e cooperazione. Per essere realmente umano il lavoro, scrive Alain Supiot, «deve dare all’homo faber la possibilità di mettere una parte di quello che è in quello che fa, di dare corpo ai propri pensieri, di far realizzare al di fuori di sé ciò che ha concepito dentro di sé»[3].
Una mera provocazione o una sfida di senso dell’apprendimento? Le funzioni HR e i people manager più attenti sono certo che vi troveranno la spinta per re-immaginare l’apprendimento e i suoi strumenti considerandolo un potente fattore di sostenibilità del lavoro.
[1] Miguel Benasayag, Funzionare o esistere?, Vita e Pensiero, Milano, 2019
[2] Nuccio Ordine, L’utilità dell’inutile. Manifesto, Bompiani, Milano, 2013
[3] Alain Supiot, «Homo faber: continuità e rotture», in Axel Honneth, Richard Sennett, Alain Supiot, Perché lavoro? Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del XXI secolo, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2020, p. 31