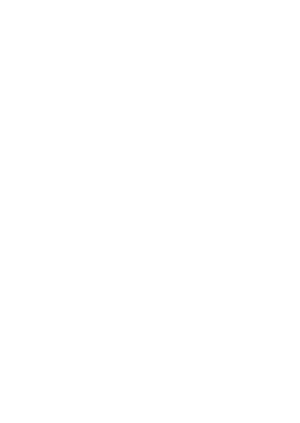Lavoro: un bene che non tira più
L’anno si apre con una certezza: la soddisfazione lavorativa è ai minimi storici. Almeno in Occidente, di qua e di là dell’oceano. I fenomeni delle c.d. dimissioni di massa (Great Resignation) e del più discreto disimpegno nel lavoro (Quiet Quitting) che hanno fatto clamore negli ultimi tempi dicono, seppur con tonalità diverse, che quel sentimento di piacevolezza che nasce dalla percezione di fare un lavoro risuonante con valori personali importanti al quale la letteratura associa la dimensione della soddisfazione lavorativa [1] è diventata merce rara.
A preoccupare ulteriormente è la circostanza che si sta affievolendo anche la motivazione a cercare questa merce (carenza di domanda) e i luoghi (anch’essi rari) dove possa essercene ancora. Meglio lasciar stare, è la convinzione che trapela, conviene abbandonare l’idea (dimostratasi ingenua) che il lavoro possa generare soddisfazione e sentimenti di benessere, mezzo per portare a compimento l’esperienza umana. È preferibile guardare altrove o cercare altro.
La profonda crisi del lavoro è racchiusa in questa ricostruzione. Viene drammaticamente illuminata da comportamenti che celano disaffezione e malessere, delusione e disincanto verso un bene (il lavoro) ormai “scaduto”, impoverito di senso e appeal. La sua domanda sempre più debole suggerisce di non esporre più questo bene, con i suoi confezionamenti ormai consunti, sugli articolati scaffali della vita. Forse può essere reperito ancora in qualche isolato interstizio di mercato, fino ad esaurimento delle rimanenze. Guai dunque investire in un bene che non tira più. Chi lo fa è destinato a non trovare ascolto e rimanere ai margini.
Perchè?
Sono andato a ricercare le dimensioni indagate «dal più popolare strumento di soddisfazione lavorativa» [2] che è il Job Descriptive Index (JDI) elaborato da alcuni ricercatori nel 1969[3]. Le dimensioni esplorate, attraverso 72 item, sono queste: work, pay, promotion opportunities, supervision, coworkers. Le ho utilizzate per leggere gli esiti delle ricerche più recenti, realizzate da Gartner e McKinsey, che si sono interrogate sulle ragioni della disaffezione crescente verso il lavoro.
Cosa scopriamo? Che sono tre le dimensioni maggiormente interessate dal fenomeno, ossia work, promotion opportunities e supervision.
Contenuti e senso del lavoro
La mancanza di un lavoro che abbia senso e che sia significativo per le aspirazioni della persona (Lack of meaningful work) è una dimensione evidenziata da entrambe le ricerche quale fattore di disaffezione nel lavoro, talvolta associato anche a situazioni nelle quali si è costretti a registrare un disallineamento tra quello che si fa e quello in cui si crede (Personal Values Misalignment). Ci sono però altri due fattori che sembrano influenzare in generale la soddisfazione lavorativa: da un lato, la circostanza che le aspettative di performance siano percepite come insostenibili lasciando immaginare condizioni di lavoro stressanti (unsustainable work pwrformance exspetaction); dall’altro, il fatto che le condizioni di lavoro possano generare anche problemi di salute (burnout).
Opportunità di sviluppo
Entrambe le ricerche segnalano poi, tra le ragioni che hanno spinto le persone a lasciare o che, al contrario, valutano come fattori importanti per rimanere, l’assenza (e viceversa la disponibilità) di opportunità di sviluppo (career development and advancement potential), ossia la percezione negativa riguardo l’interesse dell’organizzazione verso il futuro lavorativo del collaboratore (“My company doesn’t invest in me”).
Gestione
La terza dimensione che, tra quelle prese a prestito dallo strumento JDI, sembra influenzare significativamente la soddisfazione lavorativa e le scelte di abbandono o disimpegno nella nostra rilettura delle ricerche ricordate, si riferisce sostanzialmente al people management, ossia a come i manager si relazionano con e si prendono cura dei collaboratori. Questa dimensione segnala situazioni nelle quali c’è disinteresse da parte dei capi riguardo le prospettive lavorative del collaboratore (“My manager does not further my career”), ovvero indica approcci di management in generale non interessati a coltivare lo sviluppo di relazioni di cura nei confronti delle persone (Uncaring leaders). Sono situazioni queste che sembrano segnalare una carenza strutturale del management di ascoltare e adottare azioni di riconoscimento dell’altro e del suo contributo (Lack of Recognition).
Cosa fare? Dove possono investire le funzioni HR?
Le dimensioni discusse sono quelle che, pur senza trascurare la rilevanza di altri fattori indagati nelle ricerche come la flessibilità del lavoro e la qualità delle ricompense, colpiscono maggiormente per il loro impatto sulla soddisfazione lavorativa. Nella nostra visione suggeriscono a leader e manager HR di focalizzarsi su tali aspetti nell’aggiustare politiche e pratiche di gestione delle risorse umane e gli investimenti necessari. In sintesi, quello che si sta vivendo nei luoghi di lavoro domanda a gran voce di ritornare ai fondamentali del management delle persone spesso sacrificati per rincorrere il fascino di claim e tools che non generano però i risultati attesi nel lungo periodo. Inutile e controproducente è investire anche ingenti risorse economiche e organizzative in ricompense estrinseche senza accompagnarlo, anzi farlo precedere, da interventi che mirano a far sì che le persone si sentano bene “facendo quello che fanno”, siano consapevoli del significato del contributo che danno, abbiano voglia di raccontarlo in famiglia, agli amici, nella società: si sentano in altre parole “riconosciute”.
Provo a dirlo in un altro modo: manager e HR possono trovare le risposte più efficaci “dentro” e non “fuori”. Quello che voglio dire, ricorrendo a un linguaggio assai diffuso, è che l’employee centricity per diventare effettiva e concreta ha bisogno prioritariamente di una work centricity della quale invece si parla poco, anche se le leve per costruire e adeguare i sistemi organizzativi che la rendono possibile sono a portata di mano.
Se si vuole davvero rimettere sugli scaffali dell’economia e delle imprese il lavoro occorre dunque riposizionarlo culturalmente, ristrutturare componenti e packaging. Conviene lasciar da parte fiocchi, lustrini e nastri che poi vanno buttati, meglio concentrarsi piuttosto su contenuti e condizioni del lavoro per fargli riguadagnare senso e appeal. Ridisegnare il lavoro è la chiave per coltivare quella soddisfazione lavorativa che le persone non trovano più e, ancora peggio, non sembrano più credere possa essere generata dal e nel lavoro.
È proprio urgente cambiare rotta e porre mano, anche con innovativi investimenti educativi di medio periodo, al mindset dei manager per trasformare le imprese e costruire organizzazioni e lavoro sostenibili, luoghi e comunità di senso e di benessere
[1] Locke E.A., “What is job satisfaction?”, Organizational Behavior and Human Performance, Volume 4, Issue 4, November 1969, 309-336
[2] Avallone F., Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Costruire e gestire relazioni nei contesti professionali e sociali, Carocci Editore, 2011, p. 617
[3] Smith P.C., Kendall L.M., Hulin, C.L., The measurement of Satisfaction in Work and Retirement, Rand McNally, Chicago