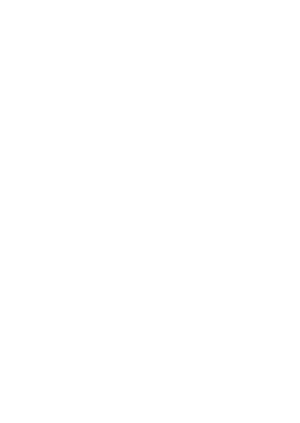Le imprese adottano molteplici decisioni sulla retribuzione: intervengono con incrementi retributivi per riconoscere il ruolo (salary review) o il merito, danno premi economici collegati alla valutazione del contributo dei collaboratori (retribuzione variabile), prevedono incentivi in funzione del raggiungimento di obiettivi prefissati. Le componenti considerate per supportare le scelte sono dunque diverse: talora è il ruolo e la sua importanza misurata con lenti che apprezzano soprattutto le responsabilità affidate; spesso è il merito indicato da una performance corrispondente alle attese e fotografata dai sistemi di valutazione adottati e fondati , per lo più, sia su risultati sia su competenze e comportamenti; per alcuni ruoli può essere il raggiungimento di obiettivi predefiniti, conosciuti e formalizzati a cui sono associate curve di prestazione e curve di incentivazione per identificare il bonus economico che dovrà essere corrisposto.
Le decisioni poi, come sappiamo, devono tener conto in generale di criteri di equità interna e di equità esterna (competitività). Il disegno delle politiche retributive per governare le ricompense in senso ampio dei collaboratori, nella cornice ormai largamente diffusa del total reward, costituisce da sempre un (possibile) terreno di conflittualità tra manager di linea e funzioni HR, nel quale si confrontano diverse concezioni del lavoro.
Due approcci, due concezioni del lavoro e dell’uomo
Un classico e acceso terreno di dibattito mette a confronto due approcci differenti alla gestione della retribuzione figli di altrettante visioni del lavoro e dell’uomo. In sintesi, può essere rappresentato così: da un lato, dalla spinta e, dall’altro, dalla resistenza ad essa a voler ampliare la diffusione di sistemi di incentivazione per obiettivi ben al di là dei ruoli di manager e venditori. Come noto i sistemi di incentivazione per obiettivi si fondano sull’assunto che i ruoli coinvolti hanno le leve per poter conseguire gli obiettivi assegnati, target che – formalmente prestabiliti – sono anche provvisti di indicatori per misurare il livello di performance conseguita, così come sono preventivamente conosciuti anche gli esiti economici del loro raggiungimento. In letteratura, proprio per queste sue caratteristiche, tale forma di variabilità retributiva viene chiamata esplicita. Questa spinta a diffondere l’applicazione dei piani di incentivazione è talvolta frenata dalle funzioni HR (ma non solo) che motiva tale resistenza ricorrendo per lo più a due controindicazioni: da un lato, evidenziando la difficoltà di identificare obiettivi che abbiano le caratteristiche descritte sopra; dall’altro, sostenendo che incentivare troppo può avere conseguenze negative nel lungo periodo e snaturare le relazioni di impiego.Si tratta di una discussione assai complessa rispetto alla quale propongo qualche riflessione a supporto di chi guarda con timore all’allargamento delle maglie incentivanti del delicato tessuto organizzativo.
Estendere l’incentivazione per obiettivi? Anche no
Una prima considerazione è questa: estendere l’incentivazione per obiettivi a discapito di strumenti di retribuzione variabile non esplicita, ossia quella il cui valore economico non è conosciuto preventivamente e che potrà essere erogato a seguito di una valutazione della performance più che positiva e di altre condizioni (politica meritocratica), significa legittimare l’idea che il comportamento umano sia sempre e solo influenzato dalla ricerca di interessi personali e dal voler guadagnare di più, quindi da una motivazione solo estrinseca ed economica.
Dietro questo atteggiamento si cela il modello dell’homo oeconomicus secondo il quale gli individui fonderebbero le decisioni unicamente sugli interessi personali, ricercando il maggior beneficio possibile in modo puramente egoistico e razionale.
In realtà sappiamo bene che non è così, che la motivazione è multi-determinata, che ci diamo da fare e ci impegniamo per diverse ragioni. Insomma non c’è solo l’interesse individuale e la razionalità economica che guidano una persona ma anche l’amore per il lavoro che si fa, la passione per la conoscenza, i valori, il purpose dell’impresa per cui si lavora, la ricerca del bene, la generosità. Una prova è che i manager cercano engagement nel lavoro, una dimensione questa che ha poco o per nulla a che fare con la ricompensa economica.
Perché abbiamo bisogno di coltivare la motivazione intrinseca
Una seconda considerazione riguarda gli effetti del progressivo allargamento di pratiche incentivanti di tal natura. Ebbene teoria e ricerca empirica mostrano che più si ricorre all’incentivazione più si depotenzia la motivazione intrinseca.
(Per dirla in maniera molto semplice a forza di incentivare accadrà che il valore di quello che prima si faceva per amore cambierà di segno, s’impoverirà di senso e lo si farà solo dietro una ricompensa, spiazzando così l’effetto di altre motivazioni (motivational crowding out).
Conviene davvero allargare a dismisura l’incentivazione?
Conviene alle imprese depotenziare la motivazione intrinseca? Offre vantaggi di lungo periodo?
Preferire incentivare, anziché premiare i risultati e i comportamenti di chi s’impegna in coerenza con i valori dell’impresa, insomma, porta reali benefici o contribuisce a far scadere le prestazioni che sono lasciate alla deriva di comportamenti opportunistici?
Potenziare le dimensioni di mercato del lavoro non va in direzione opposta a quella ricerca di engagement che assilla imprenditori e manager?
Dosare premi e incentivi è un’arte davvero complessa e la sua strada è piena di trappole: quella che ideologizza l’incentivazione per obiettivi continua ad affascinare un vasto pubblico.
di Gabriele Gabrielli
Gabriele Gabrielli, executive coach, consulente e formatore è Consigliere delegato di People Management Lab S.r.l Società Benefit e BCorp, insegna Organizzazione e gestione delle risorse umane all’Università LUISS Guido Carli. È ideatore, co-fondatore e Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona.
Contatti: conversazioni@peoplemanagementlab.it