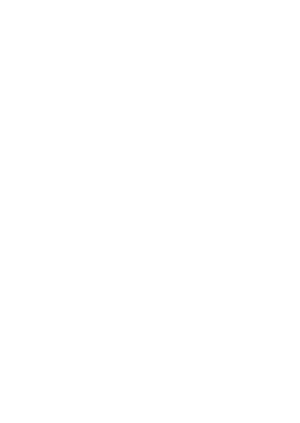L’Italia discute di salario minimo. Non si registra una visione comune sul tema che è molto articolato. L’Europa invece ha trovato l’accordo. La Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio europeo hanno raggiunto un’intesa sulla proposta di direttiva su «un equo salario minimo». La questione è complessa come sappiamo e chiama in causa numerose altre questioni. Per esempio quella della contrattazione collettiva e della sua copertura. Nel nostro paese – secondo alcuni – in realtà non ci sarebbe bisogno di definire il salario minimo per legge perché ci sono, da sempre, i riferimenti dei contratti collettivi che assicurano inoltre una copertura assai estesa. Resta il fatto però che il suo ombrello protettivo non riesce a tutelare tutti i lavoratori. Introdurre un salario minimo significherebbe allora mortificare la storia delle relazioni industriali e dell’autonomia sindacale, pilastro del nostro ordinamento costituzionale. Potrebbe anche sortire un effetto indesiderato: spronare il sistema ad appiattirsi verso il basso, insomma fungerebbe da incentivo a limitare i trattamenti salariali depotenziando l’azione collettiva e il confronto-negoziazione tra le parti. Questo accadrebbe poi quando appare preoccupante (una «emergenza sociale», secondo il rapporto Svimez) il fenomeno del «lavoro povero» che coinvolge un numero crescente di persone e famiglie che non riescono più davvero ad arrivare a fine mese (si parla di oltre 3,5 milioni di lavoratori con un reddito inferiore ai 12.000 euro l’anno). Le basse retribuzioni almeno in alcuni settori costituiscono dunque un problema emergente. Il tema dunque è molto sentito anche se le posizioni sono diverse, prova ne sono le dieci proposte di legge presentate da inizio legislatura.
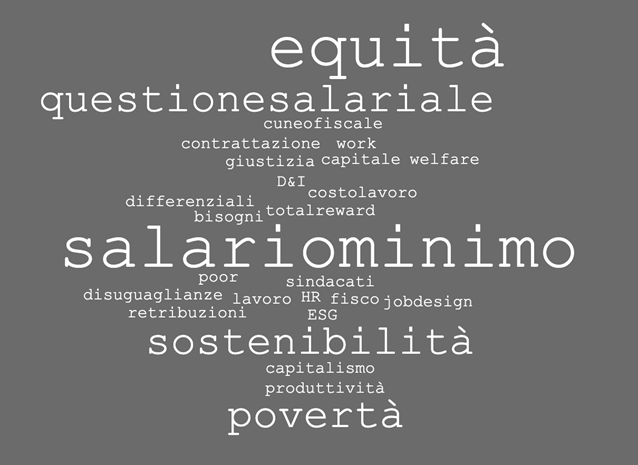
La direttiva in realtà non entrerà nel merito delle scelte che adotteranno i singoli paesi, queste infatti saranno scelte differenziate in ragione anche della situazione di partenza. La gran parte degli Stati che fanno parte dell’Unione europea d’altro canto hanno già un salario minimo. L’accordo raggiunto in Europa fa riferimento, per la definizione del salario, alla «soglia di povertà» che – si legge nel documento della Commissione europea che ha avviato la discussione – viene indicato nel 60 per cento del reddito familiare mediano disponibile, anche se non è chiaro se costituirà un riferimento indicativo (pare di sì) o obbligatorio. Se in Italia i partiti, gli studiosi, imprenditori e sindacati si confrontano portando sul tavolo le ragioni del “si” al salario minimo e quelle del “no”, in Europa si fanno i conti. Se si prendesse a riferimento il 60 per cento del reddito familiare mediano come soglia del salario minimo, infatti, per la maggior parte dei paesi europei si tratterebbe di un aumento significativo del salario minimo oggi in vigore.
La questione salariale ne intreccia tante altre
Ricordavo prima però che la discussione sul salario minimo non tocca solo la contrattazione collettiva, la soglia di povertà e le retribuzioni basse, ma tanto altro. La discussione per esempio s’intreccia con le misure del reddito di cittadinanza che vuole proporsi come un intervento per arginare la povertà economica. Ma agganciata al confronto politico-culturale-economico sul salario minino c’è anche la questione del cuneo fiscale e il suo peso eccessivo sulle retribuzioni. Molti pensano che sia proprio questo lo snodo sul quale occorre intervenire con misure strutturali e non bonus. In altre parole sarebbe questo il provvedimento da adottare con urgenza perché i salari continuano a perdere peso e con l’inflazione in crescita rischiano di diventare troppo esigui minacciando la quiete sociale.
Non è più possibile, sono in molti a rivendicarlo, che nel nostro Paese ci siano salari così bassi falcidiati dal fisco. Si tratta di una ingiustizia non più sopportabile. Ma aumentare i salari avvierebbe una spirale pericolosa, meglio mettere mano alla produttività e alla sua crescita valorizzando la contrattazione di secondo livello e il salario di produttività, anche dotandolo di un più robusto sostegno da parte della legislazione fiscale.
La giustizia organizzativa torna a interrogare tutti
E così la lista intricata dei temi che compongono la questione salariale si allunga. Su tutte incombe la questione delle disuguaglianze: tra generazioni, tra settori, tra lavori. Quella tra capitale e lavoro. Gli studi continuano a registrare una crescente diseguale distribuzione tra redditi per l’uno e per l’altro a svantaggio di chi lavora. Anche se l’evoluzione verso un capitalismo inclusivo e sostenibile, da più parti auspicato, dovrebbe invertire la rotta.
Rimane sempre poi la questione dei differenziali retributivi troppo alti tra CEO, top management, executive e il resto dei collaboratori. Almeno in alcuni settori e imprese. Si tratta di un tema di giustizia organizzativa assai controverso che non può essere dimenticato. Una gestione di buon senso, che si svincoli dalla ideologia neo-liberista che grida allo scandalo ogni volta si tenti di parlarne invocando i poteri del mercato e la sua capacità di regolazione, potrebbe aiutare a mettere a posto i pezzi del puzzle della questione salariale. Si potrà dire che da noi (in Italia e in Europa) la cultura è diversa da quella che si respira oltreoceano. Vero. Ma allora è bene non guardare a quello che succede altrove come un benchmark a cui appellarsi, seppur timidamente avendo l’accortezza di dire subito che “comunque è un caso a parte”, quando si stabiliscono i compensi degli executive e delle risorse strategiche. I benchmark talvolta, anche quelli che non vengono usati formalmente, accreditano pratiche di disuguaglianza o il tentativo di irrobustirle. Al riguardo dimenticavo di ricordare gli ultimi dati forniti da uno studio dell’Institute for Policy Studies segnalati da corriere.it del 7 giugno scorso. Secondo il report, negli Stati Uniti, il compenso medio di un CEO è arrivato ad essere pari a 670 volte quello di un lavoratore, un differenziale peraltro in crescita. Dunque, facciamo attenzione e costruiamo i riferimenti integrandoli con dimensioni de-ideologizzate e di buon senso.
Aggiungo sul punto una questione che potrebbe sembrare marginale ma non lo è affatto. Se dovesse servire ricordo che queste pratiche sono adottate in un grande paese democratico dove i sindacati però fanno ancora fatica a entrare in azienda. I lavoratori di Amazon pare ci siano riusciti e potranno ora formare un sindacato. Pensate, potranno legittimamente organizzarsi! Un articolo di Internazionale (1455 | 8 aprile 2022) avverte però che «le leggi statunitensi continuano a essere ostili ai lavoratori».
Un tema centrale e strategico per l’agenda HR
Il tempo che viviamo è pieno di sfide per i manager e le funzioni HR. Tra queste, non c’è solo il «lavoro ibrido» e il riuscire a far ritornare in azienda collaboratori che stanno riflettendo – dopo il grande esperimento sociale dello smart working obbligato – sul senso del lavoro e sul senso della vita.
Tra le sfide c’è anche quella di contribuire a costruire un mondo più giusto governando le retribuzioni, i loro assetti normativi e dinamiche. Non va mai dimenticato. Questo è il momento giusto per rimettere al centro anche la questione salariale e le sue molteplici dimensioni. Ci sono almeno tre dimensioni rilevanti:
- l’«equità» è da sempre una sfida e un’area di presidio, ma la trasformazione che viviamo vi accende oggi nuovi riflettori. Il cambiamento la fa diventare addirittura criterio per valutare il merito delle imprese e del suo management. I criteri ESG la indicano come un parametro decisivo, così a fianco alla Diversità e all’Inclusione compare l’Equità. L’acronimo D&I diventa DEI. Ma l’equità bisogna presidiarla innanzi tutto all’interno
- le relazioni industriali vanno guardate con lenti nuove che le assegnano ancora più rilevanza, anche se questa lettura è da molti osteggiata o quanto meno snobbata. In un mondo così veloce e disintermediato hanno ancora senso? Questa domanda è ispirata da un capitalismo vecchio che non può reggere le istanze di questo tempo che chiede invece «partecipazione». I sindacati sono uno dei più importanti stakeholder dell’impresa sostenibile, non bisogna dimenticarlo. Un’impresa non può essere sostenibile se non coltiva una «con-versazione continua con il lavoro»
- il concetto di ricompensa e remunerazione si amplia dando cittadinanza ad altre componenti più psicologiche e sociali. L’equità estende il suo sguardo e diventa più esigente. Avere a cuore il riconoscimento di retribuzioni e trattamenti equi richiede di andare oltre le utili ma insufficienti indagini retributive. Richiede di ancorarsi su parametri diversi da quelli fondati sulla valutazione dei ruoli. L’equità incorporerà sempre più dimensioni soggettive (preferenze, attitudini) e sociali (welfare, bisogni). L’approccio del Total Reward andrà riaggiustato per esaltare la richiesta sempre più pressante che le persone manifestano di essere «riconosciute», per estendere pratiche di progettazione di lavori (job design) che tengano in conto talenti e potenzialità di ciascuno, per ambienti di lavoro percepiti come luoghi di benessere nei quali cercare «relazioni» con capi e colleghi, collaborazione, creatività. Luoghi dove possa fiorire l’umano e il senso di quello che si fa.