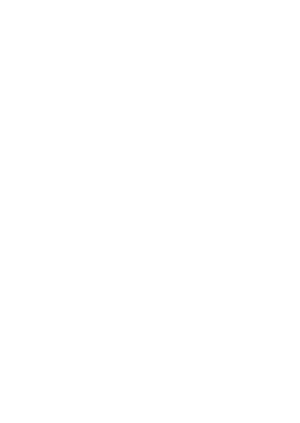Chi non ha giocato o ha visto giocare al tiro alla fune? Le più giovani generazioni lo avranno sperimentato in qualche attività di gruppo; le generazioni più mature invece lo ricorderanno come una componente sempre presente quando ci si ritrovava in piazza per giocare. Quest’immagine ci aiuta a visualizzare una negoziazione implicita che sta avvenendo in queste settimane: interessa il lavoro e l’impresa, coinvolge soprattutto i suoi protagonisti, executive, manager e collaboratori. C’è chi tira la fune da una parte e c’è chi la tira dall’altra. Ma qual è la fune e da chi sono formate le squadre? Cosa c’è in gioco? Chi può partecipare al gioco? Ebbene, in questo inedito tiro alla fune si discute e si negozia il «dove» lavorare.
Un recente sondaggio di Ipsos realizzato per il Corriere della Sera ci fornisce qualche dato interessante per la riflessione che propongo. Alla domanda posta a un campione di lavoratori, se prevedono di aumentare le ore di lavoro in smart working rispetto ai mesi precedenti, i lavoratori si sono divisi: «il 28% intende farne ricorso in misura maggiore e il 25% non è propenso». Gli altri sono rappresentati da un gruppo di indecisi (8%) e e da un significativo 39% che svolge un lavoro che non prevede questa possibilità.
Il sondaggio a tal proposito aggiunge che «tra i lavoratori esecutivi del settore privato due su tre (64%) non hanno la possibilità di lavorare in remoto».
Ritornando alla metafora del tiro alla fune abbiamo allora due questioni su cui riflettere.

Chi vincerà?
La prima questione è di natura competitiva, si interroga cioè per conoscere chi mollerà la fune. Vincerà la «squadra» che vuole continuare a lavorare o addirittura aumentare la quantità di ore da prestare in remoto? Oppure saranno più forti quanti pensano che sarebbe giunto il momento di restaurare la normalità auspicando che il lavoro ritorni in azienda?
Difficile fare pronostici perché la gara è in pieno svolgimento e differenti posizioni si stanno confrontando ormai da mesi. C’è poi un altro fatto che va ricordato. Ora in realtà, la gara simboleggiata dal tiro alla fune è di nuovo disturbata dalla pandemia che pensavamo di aver lasciato alle spalle e che invece costringe a modificare gli scenari cambiando continuamente le carte in tavola.
Quali sono dunque le motivazioni che animano i componenti delle squadre? Abbiamo elaborato i dati delle ricerche e riflettuto sull’ascolto da noi fatto in queste settimane conversando e collaborando con imprenditori, executive e responsabili HR di diverse realtà aziendali. Semplificando molto, l’idea che ci si può fare è questa: i collaboratori vogliono lavorare da casa, i loro manager vogliono che tornino in ufficio. Naturalmente è un’idea che, al suo interno, presenta molte sfumature, ma prendiamola per la sua utilità descrittiva per affinarne progressivamente la portata.
Le persone in effetti– seppur con molta fatica in tanti casi, perché hanno dovuto fare i conti con situazioni logistiche complesse – hanno cominciato ad apprezzare il «remote working». Tuttavia non immaginano, né desiderano, che tutto il lavoro venga spostato a casa. Ci sono studi infatti che mostrano come le lavoratrici e i lavoratori sentano la mancanza della presenza e delle relazioni, del confronto con i colleghi, dei benefici della socializzazione. Questo sta orientando anche la progettazione degli spazi di lavoro da parte delle imprese per rendere «attrattivo» il lavoro in ufficio. In generale però i collaboratori apprezzano il lavoro da remoto, guai a toccarlo ormai. Anche se poi si dividono – i dati del sondaggio citato supportano questa tesi – tra quanti vorrebbero aumentare le ore di lavoro in smart working e quanti invece no.
La posizione dei manager è differente, almeno secondo quanto abbiamo percepito dialogando con le imprese. Anche loro, evidentemente, hanno scoperto i benefici del lavoro in remoto; ne accusano però anche gli effetti destabilizzanti sul lavoro manageriale. Provano un senso di «spiazzamento» causato dal venir meno delle condizioni all’interno delle quali hanno imparato a gestire gli altri: presenza, controllo diretto, vicinanza, sguardi, voci, mormorii. Condizioni che consentivano loro di capire, soltanto attraversando i corridoi dell’azienda, “che aria tirasse”, chi stava guerreggiando contro chi, “sgamare” i furbetti e gli sfaticati e tanto altro, sbirciare dentro l’ufficio del capo per vedere chi c’era. Condizioni che li rassicuravano sul fatto di avere sempre sotto controllo la situazione, compresa la possibilità di intervenire subito, di dimostrare la capacità di risolvere problemi (dimenticando talvolta quella di anticiparli). Sono le componenti classiche del lavoro «vecchio», per così dire, quello cioè pre-pandemia, sulla presenza delle quali i manager hanno costruito abilità, successo e carriera.
Tutto questo ora sembra svanire; o meglio, ci sarà ancora ma in un contesto diverso e profondamente rinnovato che vedrà per forza di cose allentare la presa dei manager sulla realtà. Nella new way of working infatti queste abilità rischiano di poter essere usate solo “a intermittenza”, perché il lavoro sarà a geometria variabile. Gli schemi possono essere molti. Per esempio, qualche giorno si lavorerà in presenza insieme ad alcuni collaboratori mentre gli altri rimarranno a casa, poi si cambierà alternando presenza e distanza: la co-presenza, insomma, uno dei vessilli più solidi degli stili di management sembra sfumare. È il lavoro «phygital», ben raccontato da Raoul Nacamulli e Alessandra Lazazzara in un volume che evoca un ecosistema integrato nel quale il mondo fisico – il lavoro in presenza per creare, collaborare, socializzare – e quello digitale – attraverso l’uso delle piattaforme – possono convivere. Nei manager insomma cresce la consapevolezza che si devono allenare su nuove competenze, anche perché sarà da queste che dipenderà il loro successo nel futuro.
Che ne sarà di chi è escluso dalla sfida
La seconda questione è di natura diversa. Non ci dobbiamo dimenticare di un fatto che probabilmente si farà sentire sempre più nel medio periodo. Cosa non dobbiamo dimenticare? I dati del sondaggio richiamato ci aiutano a metterne più a fuoco i contorni ancora non nitidi.
La narrazione dei mesi passati ci ha raccontato le sorti magnifiche e progressive di quel cambiamento che ormai chiamiamo the new way of working. Un’etichetta dai contenuti commerciali che fa sognare, sprigiona visioni ma che rischia di farci perdere il senso di realtà. L’oggetto di questa narrazione infatti non interessa tutto il mondo del lavoro perché un gran numero di lavoratori continuerà ad abitare the old way of working. Parliamo – solo per fare qualche esempio – del lavoro nelle fabbriche, quello dei servizi di cura negli ospedali, dei servizi di assistenza e front-line nel commercio, quello delle attività di esercizio e manutenzione delle infrastrutture come strade, ferrovie, telecomunicazioni, cavi elettrici, il lavoro dell’edilizia, quello nei campi, senza dimenticare i lavori nel settore della logistica. Tutti questi lavori non possono essere fatti in remoto, non conoscono i vizi e le virtù dello smart working.

Sono lavoratori che non possono partecipare al tiro alla fune che mette in palio la possibilità di lavorare in smart working e in remoto. È un gioco a cui non vengono invitati, appare ai loro occhi divisivo e non inclusivo. Non tutti possono trarne divertimento e benefici, è un gioco dunque che spacca in due il mondo del lavoro creando una sempre più visibile nuova divisione del lavoro. Non si tratta più di distinguere tra colletti bianchi e colletti blu, tra manager ed esecutivi, ma tra fortunati e sfortunati, tra quelli liberi di organizzare e conciliare lavoro e vita e quelli invece che non si trovano in questa condizione perché «costretti» dal lavoro che fanno e dalla sua organizzazione.
E’ importante interrogarsi allora sulle implicazioni e sulla opportunità di costruire policy adeguate per gestirla. Questa «nuova divisione del lavoro» potrà generare nuova conflittualità all’interno? Che effetti potrà avere sull’attrattività delle imprese che cercano nuove persone e competenze da coinvolgere in un progetto aziendale “povero” di smart working? Può configurare una possibile nuova area di disuguaglianza nel lavoro che richiederà risposte e bilanciamenti da costruire sia gestionalmente sia nell’ambito del sistema di relazioni industriali?
Sono segnali deboli ma diffusi, li abbiamo ascoltati nelle imprese grazie al nostro lavoro di facilitazione di gruppi, di realizzazione di programmi formativi ed educazione manageriale. C’è un passaggio, nell’articolo che propone i principali risultati del sondaggio, che coglie la questione quando scrive: «È evidente che questa modalità di lavoro rischia, in prospettiva, di creare disuguaglianze tra le diverse categorie di lavoratori e motivi di frustrazione e di recriminazione tra chi ne è escluso».
Una nuova sfida per l’inclusione
C’è un’ultima riflessione che voglio condividere. Che effetti avrà questa nuova divisione del lavoro tra quanti fruiranno del «lavoro ibrido» e gli altri che non ne potranno beneficiare sul profilo di competenza dei manager? Non credo si possa escludere la possibilità che nel tempo ci si trovi a distinguere tra manager «competenti» a gestire team composti da collaboratori che possono lavorare sia in presenza che in remoto, e manager «competenti» a gestire team i cui componenti non possono fruirne. Avremo bisogno di spezzare l’idea, tutto sommato unitaria, del profilo manageriale distinguendo tra coloro che sanno guidare e motivare navigando nel mondo del lavoro ibrido e quelli invece che – pur usando impianti e macchine digitali – continueranno a destreggiarsi nel lavoro in presenza?
Anche questa possibile dinamica merita attenzione perché il nuovo non cancella o sostituisce sempre il vecchio. La trasformazione richiederà di far convivere le istanze della «old» e della «new way of working». Evidentemente si tratta di una nuova componente aggiuntiva, una nuova sfida che s’intreccia con quelle poste al lavoro dal paradigma dell’inclusione.