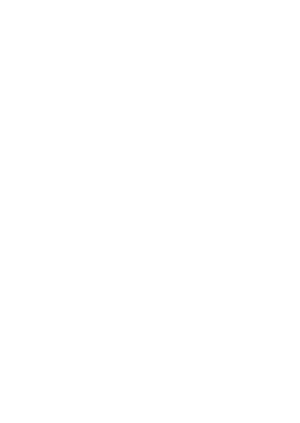Il lavoro che perde significato
C’è una nuova consapevolezza attorno al lavoro e al suo significato. La grande fuga dal lavoro, i livelli bassi di engagement nelle imprese registrati dalle impietose analisi di Gallup, la difficoltà delle aziende a ingaggiare nelle proprie fila nuovi lavoratori arrivano come un grande schiaffo.
Che succede? Cosa fa allontanare giovani e meno giovani dal lavoro? Le analisi fatte sono molte, altrettante sono quelle ancora in corso. Sì, perché questi fenomeni meritano di essere approfonditi per la loro complessità da più prospettive. Qualche mese fa hanno colpito gli esiti di una ricerca condotta dal MIT di Boston. Tra le ragioni di malessere individuate dall’analisi vi è la «cultura tossica» dell’azienda. Tossicità intesa in chiave relazionale, un fattore che inquina i rapporti con i propri colleghi e con i superiori e che devasta il senso di benessere. Lavorare in un ambiente considerato tossico e ostile è insostenibile per le persone.
Ma c’è altro oltre la tossicità che allontana le persone dal lavoro: il fatto che nel corso degli anni abbiamo deturpato il suo senso, trasformandolo in un brutto modo di impiegare il proprio tempo. Il lavoro come peso, condanna, ingiusta e insopportabile fatica. Il contrario del lavoro come progettualità, mezzo di realizzazione, strumento per generare benessere personale e collettivo: il lavoro fonte di dignità della persona.
Un sentimento sempre più diffuso
Questa situazione sta turbando gli animi di molti, prova ne è la produzione di riflessioni e scritti che nelle ultime settimane hanno provato a illuminare le virtù del lavoro. Giuseppe Soda a gennaio[1] ha richiamato l’attenzione sul fatto che si sta parlando molto di “quanto” e di “dove” lavorare, molto meno invece di “come” lavorare, ossia dei contenuti e della qualità del lavoro. Nella sua analisi lamenta che abbiamo lasciato indietro, dimenticandolo, un aggettivo: la grande bellezza del lavoro che dà il titolo al suo intervento.
Mi piace condividere anche la riflessione di Pietro Ichino sul “lavoro attraente e il suo contrario”. Nel commentare un saggio di Camillo Berneri e il pensiero di Primo Levi, ripercorre anche le indicazioni che sul lavoro sono date dal diritto europeo e dal nostro ordinamento giuridico, ricordando come “l’amore per il proprio lavoro” dipende da due fattori. Certamente da circostanze esterne, come l’organizzazione del lavoro e l’ambiente, rinviando così alla responsabilità dell’impresa. Ricorda però che oltre all’obbligo giuridico che ha l’imprenditore (e il management) di «creare le condizioni perché ogni persona che vi è inserita, dalla prima all’ultima, possa amare il proprio lavoro» c’è un secondo fattore che influenza l’atteggiamento verso il lavoro. A differenza del primo questo “alberga” in ciascuno di noi perché, cita al riguardo un passaggio de La chiave a stella di Primo Levi, dipende “molto dalla storia dell’individuo”, rinviando così all’importanza dei contesti sociali, economici ed educativi in cui si cresce. Contesti nei quali nei decenni passati sono stati gettati semi che hanno fatto crescere molta erbaccia attorno al lavoro e al suo senso. Walter Passerini scrive che «il lavoro è stato dirottato a merce di scambio, non è più un valore. È un fastidio, un sacrificio, una fregatura, un problema». Passerini lamenta che «sono finiti i tempi in cui era identità e dignità» e si domanda: «Come è possibile recuperare il “mito del lavoro” quando la sua immagine è stata distrutta?»
Come ridare allora significato al lavoro perché possa ritornare ad essere “bello”? Intorno a questa domanda Alfonso Fuggetta costruisce la sua riflessione «perché il lavoro è una dimensione nella quale esprimiamo la nostra creatività e capacità realizzativa; è un’occasione di crescita, non solo professionale ma anche culturale e umana, tramite la quale valorizzare molti aspetti di noi stessi». Per questo non ci basta più avere «un lavoro», ma vogliamo «un bel lavoro».
Una nuova alleanza per rigenerare il senso del lavoro
Le persone sono in cerca di un lavoro che dia «senso» alla loro esistenza. È miope allora quella cultura manageriale, ancora diffusa e prevalente, che pensa di gestire (e generare) motivazione e performance con il denaro.

Sicuramente la ricompensa economica è importante, ma le persone nel lavoro cercano anche altro; cercano senso, socialità e benessere.
Daniel H. Pink ricorda che sono tre i fattori principali che agiscono sui livelli di motivazione: l’autonomia, che nasce dal bisogno umano di imprimere una direzione alla propria esistenza, la competenza e lo scopo, ossia poter collocare le nostre azioni all’interno di uno schema di senso più ampio.
Sono tre fattori costitutivi del lavoro sostenibile, attorno ai quali è necessario – come ho scritto recentemente – ridisegnare il lavoro per costruire luoghi che generano e rigenerano il senso del lavoro «come strumento di realizzazione, di sostentamento per rispondere ai bisogni di se stessi e della famiglia, di occasione di crescita sociale per coltivare legami, senso di appartenenza e identità».
Non è facile però, perché richiede una grande fatica, quella di «recuperare i progressivi slittamenti di significato del lavoro diventato, a seconda dei casi, solo fatica che abbrutisce, mezzo per arricchirsi e strumento per competere e far prevalere i nostri interessi, risorsa per consumare e assecondare desideri piuttosto che strumento per rispondere a bisogni fondamentali, merce tra merci che può essere liberamente acquistata e venduta in una società che, sotto i nostri occhi, abbiamo trasformato in un grande mercato, uno sfavillante e impersonale centro commerciale».
Occorre ri-leggere e ri-scrivere le pratiche HR, per farlo c’è bisogno di una nuova alleanza fra tutti gli attori, dentro e fuori l’impresa
[1] Giuseppe Soda, Non dimentichiamo la grande bellezza del lavoro, L’Economia, 16 gennaio 2023