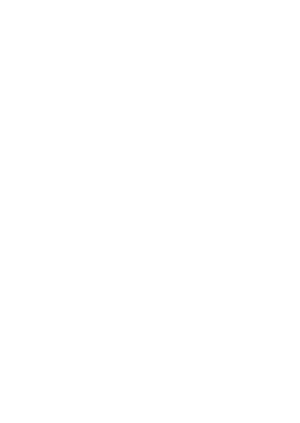In generale, ma soprattutto quando parliamo di sostenibilità per declinare il suo paradigma nelle pratiche di gestione di collaboratrici e collaboratori nei contesti di lavoro, dovremmo preferire l’espressione gestione sostenibile delle «persone» anziché quella di gestione sostenibile delle «risorse umane».
Quando usiamo il termine “risorsa”, infatti, stiamo guardando l’altro come strumento, come mezzo per me, per perseguire i miei interessi. È il parametro di utilità che mi guida, vuol dire cioè che quella “risorsa” potrà non essermi più utile se diventerà ai miei occhi obsoleta o poco performante; se finisce di avere un valore per me. Posso così avviare con una certa tranquillità, anche morale, un processo di dismissione o, se ho troppi vincoli da gestire, limitarmi a marginalizzarla allontanandola dai processi vitali dell’impresa. Quando considero e indico gli altri come risorse umane, infatti, sto dicendo implicitamente due cose molto importanti.
La prima è che posso dare loro un “prezzo”, quindi posso farle diventare una merce come le altre. Magari non ce ne rendiamo conto, o non vogliamo, ma stiamo considerando l’altro così.
La seconda è che considerandole in questo modo, alla stregua cioè di una merce che ha un prezzo, potrò sostituirle con qualcos’altro appena troverò – anche grazie all’innovazione – una risorsa “equivalente”.
Cosa vuol dire? Sostanzialmente sto sostenendo che quella “risorsa” non ha un valore in sé, lo ha in quanto e fintanto la posso impiegare per raggiungere un obiettivo. Ho ridotto in altre parole la “risorsa umana” alla dimensione del funzionare e non dell’esistere. Una situazione che il filosofo e psichiatra Benasayag descrive bene in un suo lavoro [1].
Travolti dalla velocità con cui guidiamo la vita e il business pensiamo poco a come usiamo le parole. D’altro canto nel linguaggio comune, in quello manageriale e accademico si usa “risorsa umana”; i motori di ricerca hanno questo termine nel loro algoritmo di indicizzazione. Se usassimo “persona” la ricerca ci porterebbe altrove. Ma le parole sono importanti perché celano il loro vero significato. Come scrive Gianrico Carofiglio, non si possono manomettere. C’è un passaggio del volume a cui mi sto riferendo, La nuova manomissione delle parole [2], che ci aiuta a meglio interiorizzare questa discussione. Scrive Carofiglio:
“Le parole sono anche atti, dei quali è necessario fronteggiare le conseguenze.
Esse sembrano non avere peso e consistenza, sembrano entità volatili, ma sono in realtà meccanismi complessi e potenti, il cui uso genera effetti e implica (dovrebbe implicare) responsabilità.
Le parole fanno le cose …”
Le parole contano allora e contano molto, perché «fanno» le cose, creano la realtà in cui viviamo. C’è un’obiezione che ascolto di frequente e suona così. «Guarda che ormai quando si usa la parola risorsa umana sono davvero in pochi a usarla nel suo senso più vero. In generale, chi la usa la usa come sinonimo di persona non avendo in mente quello che dici». Capisco ma credo sia importante fare uno sforzo.
Possiamo ben dire che quando usiamo “risorsa umana” non intendiamo considerarla un fattore produttivo come gli altri, che non c’è ormai articolo scientifico che usi “risorsa umana” assegnandole questo significato. Allora mi domando: se usiamo una parola che non vogliamo usare per quel che significa ma per altro, perché continuiamo ad utilizzarla nel modo sbagliato?
Il punto è che le intenzioni comunicazionali diverse che ha chi usa risorsa umana non sono visibili, perché la parola esprime un significato, rinvia a un concetto che con discrezione costruisce, modella e consolida la realtà.
[1] Miguel Benasayag, Funzionare o esistere?, Vita e Pensiero, 2019.
[2] Gianrico Carofiglio, La nuova manomissione delle parole, Feltrinelli, 2021.